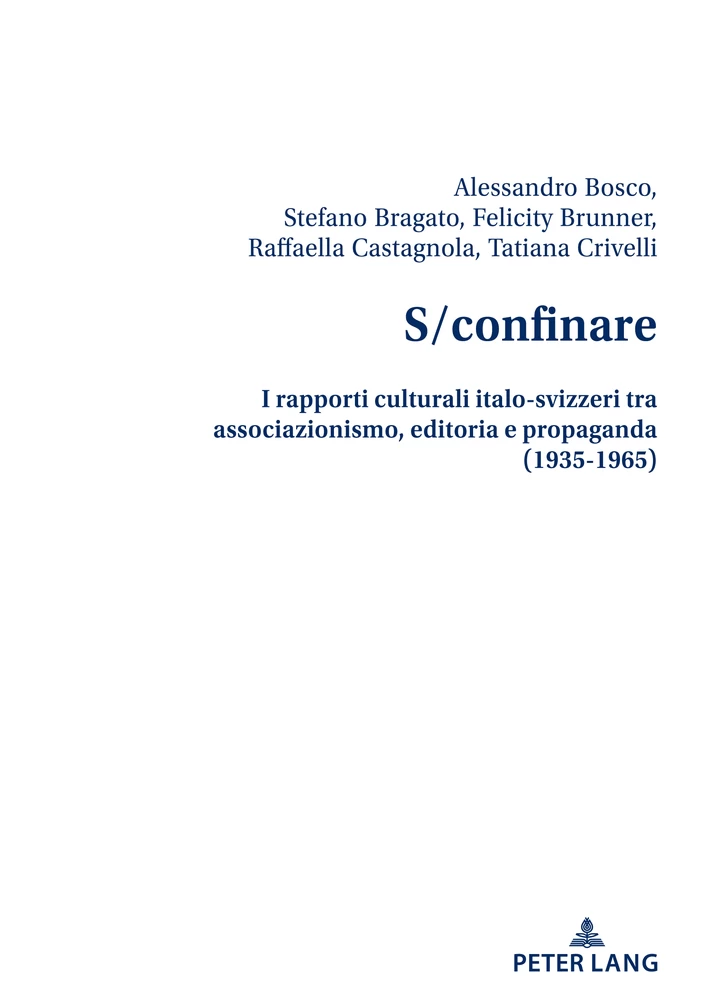S/confinare
I rapporti culturali italo-svizzeri tra associazionismo, editoria e propaganda (1935-1965)
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Copertina
- Titolo
- Copyright
- Sull’autore
- Sul libro
- Questa edizione in formato eBook può essere citata
- Indice
- Introduzione (Tatiana Crivelli)
- Ringraziamenti
- Nota al testo
- I. Luoghi
- 1. L’Associazione Svizzera per i Rapporti culturali ed economici con l’Italia (1937-1967) (Alessandro Bosco)
- 2. Il Centro Studi per la Svizzera italiana (1941-1943) (Stefano Bragato)
- 3. L’Associazione Italo-Svizzera di Cultura (1945-1952) (Alessandro Bosco)
- II. Temi
- 1. Italianità (Stefano Bragato)
- 2. Elvetismo (Felicity Brunner)
- III. Percorsi
- 1. Arte e propaganda. Maraini, Scheiwiller e la mostra Pittori e scultori italiani contemporanei al Kunsthaus di Zurigo (1940-1941) (Alessandro Bosco)
- 2. «E cantano ancora». Un capitolo inedito della ricezione di Max Frisch in Italia (1946-1959) (Alessandro Bosco)
- 3. Editoria transculturale: Eros Bellinelli e i progetti editoriali Il Roccolo e Pantarei (Stefano Bragato e Raffaella Castagnola)
- Bibliografia
- Indice dei nomi
Introduzione
Oltre confine. Un trentennio di circolazione letteraria e culturale tra Italia e Svizzera (1935-1965)
In short, we face as a nation the deep, profoundly perturbed and perturbing question of our relationship to others--other cultures, states, histories, experiences, traditions, peoples, and destinies. There is no Archimedean point beyond the question from which to answer it […]. We are, so to speak, of the connections, not outside and beyond them.*
Sono trascorsi quasi trent’anni da quando l’Edward Said di Cultura e imperialismo metteva a fuoco, con la sua abituale capacità di penetrazione concettuale, una delle questioni chiave della relazione tra culture: non esiste il punto archimedico su cui far poggiare la decodifica dell’alterità, né il luogo distaccato da cui osservarla grazie a una prospettiva esterna. Nessuno/a, insomma, può vantare il privilegio epistemologico di interpretare «culture, stati, storie, esperienze, tradizioni, popoli e destini» altrui collocandosi al di là di una relazione che lo/la coinvolga direttamente: «We are, so to speak, of the connections, not outside and beyond them». E in tempi come i nostri, in cui una pandemia ci ha improvvisamente mostrato cosa significhi essere veicoli di trasmissione e in cui si è fatta tragicamente palese la permeabilità dei confini nazionali, la questione dell’interconnessione tra «culture, stati, storie, esperienze, tradizioni, popoli e destini» si presenta nella sua più bruciante attualità. Altrettanto scottante, del resto, è oggi la domanda relativa al ruolo che compete all’intellettuale umanista, figura ormai definitivamente deprivata di quella credibilità sociale che per secoli l’aveva costituita garante super partes della verità e che, nei casi migliori, ha volontariamente abdicato a questo ufficio di legislatore per passare, per dirla con Bauman ma senza la sua amarezza di fondo, a quello di interprete.1 Se l’intellettuale umanista moderno era un arbitro il cui giudizio, in base all’autorità conferitagli dal proprio sapere, era vincolante e le cui verità avevano ←7 | 8→carattere universale e rilevanza diretta per l’ordine sociale, l’intellettuale contemporaneo/a non ha più il ruolo di chi giudica e legifera, bensì, quello, solo apparentemente più modesto ma politicamente non meno significativo, di chi si adopera per «tradurre affermazioni, fatte all’interno di una tradizione fondata sulla comunità, in modo tale che possano essere capite all’interno del sistema di conoscenza basato su di un’altra tradizione».2 L’intellettuale odierno/a, insomma, è la connessione.
I due elementi ora delineati – da un lato la consapevolezza, acquisita in particolare grazie al contribuito degli studi sulla subalternità e, più in generale, dall’approccio intersezionale degli studi (post)umanistici, di vivere in connessione e dentro la connessione, e, dall’altro, l’interesse per la ridefinizione del ruolo dell’intellettuale – sono stati anche il nucleo generatore del progetto di ricerca da cui nasce questo volume. Lo studio dei rapporti culturali tra Svizzera e Italia nei tre decenni tra il 1935 e il 1965, anni in cui gli eventi storici modificarono drasticamente le relazioni tra i due i paesi confinanti, si è infatti confermato un terreno esemplare su cui osservare sia il farsi di costruzioni identitarie tra loro strettamente embricate, anche nei momenti in cui più marcati si facevano i distinguo, sia il ruolo della cultura umanistica nell’elaborazione e circolazione di tali costruzioni, prendendo in esame nello specifico l’opera di letterati/e, osservati/e nel loro rapportarsi con le rispettive istituzioni di riferimento. Dall’apogeo del fascismo allo sfacelo della guerra e fino alla ricostruzione, infatti, le relazioni tra le due nazioni – da sempre particolarmente sensibili anche in virtù di una parziale, ma simbolicamente rilevante comunanza di lingua, letteratura e tradizione culturale – hanno assunto e generato forme paradigmatiche del rapporto complesso con l’alterità. Del resto, per citare ancora una volta le parole di Bauman,3 ogni definizione che l’intellettuale moderno propone di sé e della propria tradizione di riferimento, anche quando sembri autoreferenziale, in realtà «costituisce un tentativo di tracciare il confine della […] propria identità. Ogni confine divide in due parti il territorio: di qua e di là, dentro e fuori, noi e loro. Ogni autodefinizione è in definitiva l’affermazione di una opposizione segnata dalla presenza di un elemento di distinzione da una parte del confine e dalla sua assenza dall’altra».
Sotto il titolo programmatico di La gita a Chiasso. Trent’anni di sconfinamenti culturali tra Svizzera e Italia (1935-1965)4 abbiamo dunque preso in ←8 | 9→esame l’intenso e a tratti controverso dialogo intellettuale tra i due paesi confinanti, ricostruendone le coordinate teorico-ideologiche, rintracciandone le figure protagoniste e delineandone le strategie, i luoghi e le modalità d’azione. Ad emblema di questo progetto abbiamo posto una nota esortazione di Alberto Arbasino che, nel 1963, invitava la cultura italiana a sprovincializzarsi, ad andare oltre confine:
Bastava arrivare fino alla stanga della dogana di Ponte Chiasso, due ore di bicicletta da Milano, e pregare un qualche contrabbandiere di fare un salto alla più vicina drogheria Bernasconi e acquistare, insieme a un Toblerone e a un paio di Muratti col filtro, anche i Manoscritti economico-filosofici di Marx (1844), il Tractatus logico-philosophicus di Wittgenstein (1921) […].5
Details
- Pages
- 196
- Publication Year
- 2022
- ISBN (PDF)
- 9783034345590
- ISBN (ePUB)
- 9783034345606
- ISBN (MOBI)
- 9783034345613
- ISBN (Softcover)
- 9783034345583
- DOI
- 10.3726/b20093
- Open Access
- CC-BY
- Language
- Italian
- Publication date
- 2022 (September)
- Keywords
- Rapporti italo-svizzeri Sconfinamenti culturali tra Italia e Svizzera Mediazione culturale
- Published
- Bern, Berlin, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2022. 196 p., 5 ill. b/n.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG