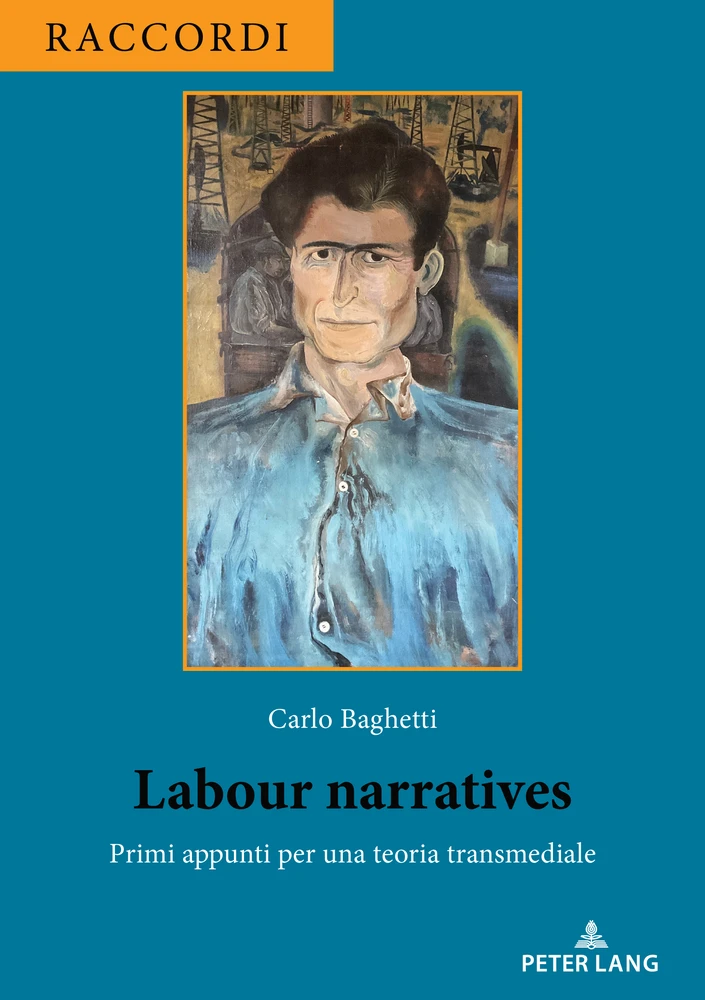Labour Narratives
Primi appunti per una teoria transmediale
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Copertina
- Titolo
- Copyright
- Sull’autore/Sul curatore
- Sul libro
- Questa edizione in formato eBook può essere citata
- Indice
- Premessa
- Prima parte
- Sull’utilità e funzionamento delle labour narratives
- Letteratura e lavoro: una premessa necessaria
- Lavoro, un concetto in continua evoluzione
- Fine del lavoro, flessibilità e precarietà esistenziale
- Nuovi studi sul lavoro: un’interdisciplinarietà necessaria
- Il lavoro nelle rappresentazioni culturali
- La critica letteraria e le rappresentazioni del lavoro
- Le labour narratives, una serie di domande e una premessa
- Labour narratives: una categoria lasca
- Il principio d’“intensità” nelle labour narratives
- Seconda parte
- Primo elemento: la struttura narrativa
- Labour narratives e il principio d’intensità
- Struttura narrativa ricorrente
- Lo schema narrativo in una Labour Narrative ad “alta intensità”: Works di Trevisan
- Secondo elemento: le metafore ricorrenti
- Il bestiario
- Malattia, morte e racconto della fine
- Inferni, cattedrali, carceri e lager
- Terzo elemento: i topoi
- Colloquio e assunzione
- Descrizione del lavoro
- Licenziamento, dimissioni e fine del contratto
- Vecchie e nuove lotte
- Quarto elemento: motivi ricorrenti
- Nature del lavoro: l’eclissi e la fine
- Psiche e lavoro
- Casa e lavoro: una coppia in crisi
- Terza parte
- Per un attraversamento transmediale: autunno caldo e labour narratives
- Conclusioni provvisorie
- Tra limiti e potenzialità: per uno sviluppo delle labour narratives
Premessa
Il presente saggio ha una storia e un percorso laborioso – è il caso di dirlo – che proverò a descrivere brevemente in questa Premessa. L’interesse per la materia nasce da uno studio che realizzai tra il 2010 e il 2011 nell’ambito delle ricerche per l’ottenimento della laurea magistrale1 presso l’Università degli Studi di Roma, “La Sapienza”. In quel momento la mia attenzione era attirata dalla rappresentazione dell’azienda e, in particolare, di come la narrativa – francese e italiana, poiché era una tesi in letteratura comparata – avesse raccontato lo spazio dell’ufficio, che nell’immaginario collettivo aveva scalzato la fabbrica come luogo di lavoro e di produzione per eccellenza.
Già durante le letture preparatorie mi ero reso conto che l’ufficio e l’azienda, nei racconti dei prosatori, erano luoghi in cui si dipanavano narrazioni critiche verso la svolta neoliberale dell’economia internazionale a cui, con più o meno fatica, con più o meno resistenze, il terziario dei due paesi analizzati andava adattandosi. La letteratura raccontava delle storie ambientate in questi ambiti e contribuiva alla definizione di un nuovo tipo antropologico, l’homo instabilis, come poi venne definito dai sociologi2.
Lo studio magistrale mi consentì dunque una prima esplorazione del corpus e la definizione di alcune domande di ricerca che avrei in seguito affrontato, stavolta in una dimensione nazionale (italiana), durante il dottorato: come viene raccontata dalla letteratura la svolta neoliberale e la trasformazione del lavoro? Come si strutturano questi racconti? E cosa ci dicono dell’evoluzione della letteratura italiana contemporanea? Per tentare di rispondere a queste e altre domande bisognava certamente studiare le rappresentazioni letterarie scritte a partire dall’inizio degli anni Ottanta – sebbene una produzione più fitta iniziasse solamente un quindicennio più tardi, a metà degli anni Novanta – ma era inevitabile tentare un confronto con la produzione precedente, la cosiddetta “letteratura industriale”, che fu prodotta tra il Secondo dopoguerra e la fine degli anni Settanta.
Gli studi di dottorato diedero vita a una tesi di oltre settecento pagine, divisa in tre parti: un’analisi microtestuale di quattro romanzi considerati come “paradigmatici”3, un capitolo d’impronta più tematica e un altro che si proponeva di ragionare, su scala più ampia, agli orientamenti della letteratura contemporanea italiana visibili dalla specola delle narrazioni studiate. La prima idea per il saggio era di fare un adattamento o piuttosto una riduzione di quello studio. La fine del dottorato ha coinciso però con l’inizio di una fase professionalmente turbolenta in cui, dopo aver studiato le rappresentazioni del precariato, ne facevo l’esperienza diretta nella sua declinazione accademica e mi ritrovavo a studiare e scrivere progetti di ricerca per concorsi di post-dottorato che inevitabilmente richiedevano tempo e sforzi e studi che, allo stesso tempo, allontanavano e ridefinivano l’oggetto delle ricerche rimasto – con qualche aggiustamento prospettico – sempre nell’alveo di quelle iniziali: le rappresentazioni letterarie del lavoro.
Il primo post-dottorato, alla Casa de Velázquez (École des Hautes Études Hispaniques et Ibériques) di Madrid, è stato l’occasione per studiare la produzione letteraria – con qualche incursione nel fumetto – spagnola sul medesimo argomento e aggiungere un tassello, seppur incompleto e parziale, su un terzo paese che si affaccia sul Mediterraneo; mentre il secondo e terzo postdoc, entrambi presso l’Institut Créativité et Innovation dell’Aix-Marseille Université (in particolare presso due laboratori di ricerca: il Centre Gilles Gaston Granger specializzato in filosofia e il Laboratoire d’Économie et Sociologie du Travail), mi hanno consentito di rafforzare questo approccio transnazionale alle rappresentazioni letterarie del lavoro. L’occasione di frequentare da vicino centri di ricerca e colleghi che non fossero solamente italianisti o comparatisti, bensì filosofi, storici, sociologi, antropologi, economisti, linguisti, informatici, insomma avendo la fortuna d’istaurare un dialogo fitto, diretto e costante con uno spettro allargato di specialisti delle scienze umane e sociali interessati al lavoro ha avuto un impatto decisivo sulla maniera in cui vedevo l’oggetto delle mie ricerche e di come pensavo l’interdisciplinarità possibile dei miei studi.
Ovviamente, essendo il lavoro un argomento centrale nelle vite dei cittadini ho avuto chiaro fin dall’inizio il possibile impatto sociale di queste ricerche e la loro apertura interdisciplinare, ma è stato attraverso le domande, talvolta dirette (Perché serve studiare la letteratura del lavoro? Cosa ci dicono i racconti che noi non sappiamo già?) poste dai colleghi incontrati in queste istituzioni che sono riuscito a mettere a fuoco davvero l’utilità – termine problematico e scivoloso quando si tratta di artefatti culturali – degli studi che si potrebbero compiere sui racconti del lavoro. E più mi rendevo conto di questa utilità, soprattutto nell’ottica delle scienze sociali, che raramente4 si confrontano con le rappresentazioni artistiche, e più mi sembrava necessario dare una definizione di cosa sia il mio oggetto di studi, di cosa possiamo mettere sotto l’ampio cappello di labour narratives.
Il progetto monografico tratto dalla tesi di dottorato, mentre cambiavo prospettiva sui miei studi grazie a un’immersione interdisciplinare sempre più forte, rimaneva in attesa di una revisione, ma ero consapevole che quanto fatto in precedenza non poteva essere pubblicato in quel modo, che era necessario un lavoro di definizione e ridefinizione più preciso che rispondesse alle domande dei colleghi delle scienze sociali: perché studiare il lavoro attraverso l’arte? Cosa ci dice di diverso che le altre scienze non dicono? Mentre cercavo (e sto ancora cercando) la risposta a queste domande alcuni avvenimenti mi convincevano che, sebbene gli argomenti di cui ero in possesso non fossero definitivi e schiaccianti, forse ero – anzi eravamo, e non è un plurale maiestatis – sulla giusta via: insieme a Erica Bellia, Marzia Beltrami, Carmela Lettieri e Mariagrazia Cairo avevamo deciso di organizzare un convegno intitolato Narrating Labour: Posture and Positionality, punto di arrivo e di partenza dei lavori svolti (tra difficoltà varie e, soprattutto, la pausa forzata dovuta al Covid-19) all’interno dell’Observatoire Européen des Récits du Travail (OBERT), che avevo co-fondato nel 2018 presso l’Aix-Marseille Université.
Le risposte ottenute furono sorprendenti: ricevemmo circa un centinaio di proposte, molte da colleghi italiani e francesi, dove gli studi sul lavoro sono ben impiantati, ma anche da ricercatori statunitensi, indiani, britannici, spagnoli, tedeschi, cechi, egiziani, greci, olandesi, svizzeri e da molti altri paesi. Non solo: gli estensori delle proposte erano in maggioranza esperti di rappresentazioni culturali (letteratura e cinema soprattutto), ma vi erano anche storici, sociologi, filosofi, addirittura un medico. È in quel momento che ci siamo resi conto che l’approccio culturalista e narrativo al lavoro era condiviso o condivisibile da molti studiosi e che stavamo contribuendo a definire un ambito di ricerca interdisciplinare e in forte espansione.
L’ultimo tassello è stato aggiunto grazie al sostegno dell’Agenzia Nazionale della Ricerca francese (ANR) che mi ha accordato un finanziamento di due anni per preparare un progetto ERC dedicato alle labour narratives. Dopo vari anni in cui ho ripensato allo studio approntato per il dottorato, aperto e chiuso la bozza della monografia accordandomi più tempo, ho sentito che era il momento di modificare il progetto iniziale e abbandonare l’idea di una riduzione della tesi di dottorato, perché i presupposti non erano più li stessi: dovevo provare a definire un po’ meglio cosa intendo per labour narratives, mostrarne il funzionamento, almeno parziale, mettere in luce alcune metodologie, potenzialità, punti di contatto possibili con le altre discipline.
Infatti, nel periodo intercorso tra le prime ricerche e la pubblicazione di questa monografia il lavoro stesso è cambiato ed eventi di portata storica sono intervenuti a modificarne la percezione: dagli effetti devastanti della crisi economica e della recessione post-2008 alle consapevolezze e conseguenze di quella sanitaria dovuta al Covid-19. In questo contesto storico e culturale si è registrata una grande fioritura di rappresentazioni del lavoro nelle varie discipline artistiche, dalla letteratura al cinema, dal fumetto alle serie tv, dalla fotografia al teatro; così, da argomento liminare e confinato a racconti dalla forte vocazione politica e impegnata (come poteva ancora essere il caso della produzione letteraria del Secondo dopoguerra) oppure accessorio (perché considerato banale e afferente a un quotidiano che non meritava d’essere nobilitato dal racconto), il lavoro è pian piano diventato un argomento ampiamente presente nelle rappresentazioni artistiche e declinato con vari linguaggi e modalità. Una presenza talmente importante che, come diremo diffusamente nel corso della prima parte di questo studio, sembra trascendere i limiti di una narrazione a tema: quanto più ci avviciniamo all’oggi e a un tempo che accorda al lavoro una posizione predominante (nonostante tutte le resistenze, alcune delle quali provenienti proprio dalla sfera artistica e intellettuale), ci rendiamo conto che il lavoro è un materiale per raccontare l’umano nel suo divenire sociale e questo ci obbliga a cambiare il nostro sguardo critico su questa produzione. Non si tratta più (solamente) di riconoscere e strutturare all’interno di un filone coerente delle narrazioni a sfondo lavorativo come è stato fatto in passato per la “letteratura industriale”, la “letteratura del precariato”, la “letteratura aziendale” o, più di recente, la “letteratura working class”, ma di intercettare e analizzare il racconto del lavoro all’interno di rappresentazioni eterogenee, di aprire la categoria e abbracciare con lo sguardo un territorio molto più vasto e dai confini mobili, dall’intensità variabile: le labour narratives.
Ecco, quindi, che delle oltre settecento pagine di tesi di dottorato ne ho salvate, ristrutturate e riscritte un centinaio abbondante, una sorta di galleria di temi, motivi, topoi di tali produzioni culturali che hanno la duplice funzione di illustrare il funzionamento tematico di questi testi, ma anche di proporre un modello metodologico per future ricerche in questo ambito. A ciò, si sono aggiunte due sezioni nuove: il primo capitolo, in cui ho cercato di definire nel modo più chiaro possibile cosa intendo per labour narratives e perché le etichette critiche che abbiamo finora utilizzato potrebbero e dovrebbero essere raccolte sotto una più ampia categoria che favorisca l’interdisciplinarità; e il capitolo finale in cui ho voluto mostrare concretamente uno dei possibili attraversamenti che la materia permette, concentrandomi sulla rappresentazione transmediatica di una figura storicamente e socialmente rilevante come l’operaio-massa. In questa lettura ho utilizzato un testo letterario, Vogliamo tutto di Nanni Balestrini (1971), un brano musicale, La ballata della Fiat di Alfredo Bandelli (1970) e un film, Mimì metallurgico ferito nell’onore di Lina Wertmüller (1972).
La forma attuale assunta dal saggio, sebbene non possa dirsi completa ed esauriente, aggettivi che si accompagnano difficilmente a uno studio che si propone di mappare un territorio ampio e nuovo come quello descritto nelle pagine che seguono, credo che sia perlomeno aderente all’idea che ho oggi della materia a cui ho dedicato un quindicennio di ricerche, molto più ricca, complessa, persino complicata, di quando ho sostenuto, nel 2019, la tesi di dottorato.
1 Il titolo scelto per la tesi era Il tema del lavoro (in ufficio) nella letteratura contemporanea italiana e francese.
2 Homo instabilis. Sociologia della precarietà, a cura di Mario Aldo Toscano, Milano, Jaca Book, 2007.
3 I testi erano quelli di Sebastiano Nata, Il dipendente, Roma, Theoria, 1995; Ermanno Rea, La dismissione, Milano, Feltrinelli, 2014 [2002]; Giorgio Falco, Pausa caffè, Milano, Sironi, 2004; Vitaliano Trevisan, Works, Torino, Einaudi, 2016.
4 La sociologia dell’immaginario, la storia dell’idee, l’antropologia sono alcune branche del sapere che studiano artefatti culturali, restando tuttavia minoritarie all’interno delle rispettive discipline.
Details
- Pages
- 238
- Publication Year
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9782875744739
- ISBN (ePUB)
- 9782875744746
- ISBN (Softcover)
- 9782875744722
- DOI
- 10.3726/b22185
- Language
- Italian
- Publication date
- 2024 (December)
- Keywords
- Labour narratives lavoro rappresentazione culturale cultural studies letteratura italiana XX-XXI secolo labour studies
- Published
- Bruxelles, Berlin, Bern, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2024. 238 p., 1 ill. b/n.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG