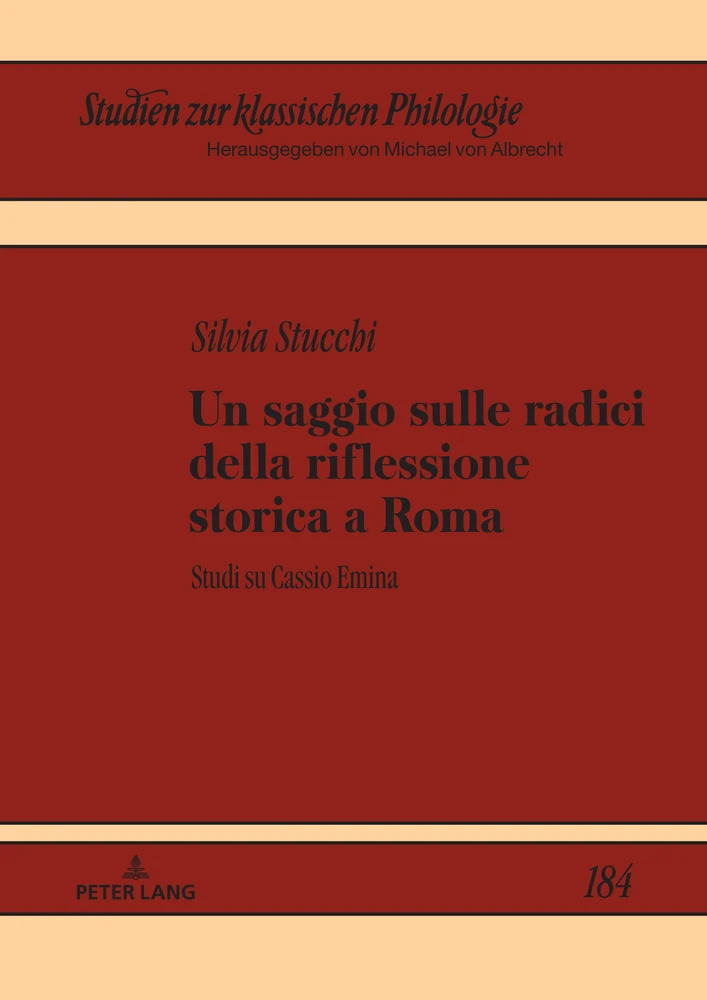Un saggio sulle radici della riflessione storica a Roma
Studi su Cassio Emina
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Copertina
- Titolo
- Copyright
- Sull’autore/Sul curatore
- Sul libro
- Questa edizione in formato eBook può essere citata
- Indice
- Introduzione
- Capitolo 1 Tra Evemero e Pitagora: riflessioni su alcune forme del razionalismo in Cassio Emina
- Capitolo 2 I Lares Grundiles e i gemelli sul trono
- Capitolo 3 Osservazioni sul suicidio degli operai delle cloache
- Appendice Evemero nell’Europa del XVIII secolo: il caso di Voltaire
- Bibliografia
- Indice dei nomi, dei concetti e delle cose notevoli
Introduzione
1 Perché Cassio Emina?
Per quale motivo scegliere, come argomento di studio, Cassio Emina?
Egli, autore semisconosciuto ai più, oscurato dalla fama di Catone e di cui ci restano una quarantina di frammenti, tuttavia, dovette essere una personalità se non eminente, certo emblematica nella letteratura e nella storiografia arcaiche: fu infatti autore di Annales dedicati, nei primi due libri, alla storia di Roma, dalle origini mitiche e dalla fondazione della città (fissata al 753 a. C.), sino al sacco gallico del 390 a. C., e che, nella parte successiva dell’opera, trattavano le vicende intercorse dalla seconda guerra punica alla distruzione di Cartagine nel 146 a. C.1
Questo periodo della storia letteraria romana rappresenta un campo d’indagine al contempo affascinante e periglioso: lo stato frammentario in cui ci è pervenuta gran parte delle testimonianze rende molto arduo fruire di questa letteratura, la quale, però, a un occhio appena attento, rivela una ricchezza a torto e troppo a lungo sottovalutata. Va ribadito, come ormai è uso fare, che “a Roma la letteratura è un fenomeno tardo”2: in effetti, devono passare cinque secoli di lotte interne ed esterne a Roma prima che si senta il bisogno di affiancare a quella in lingua greca una produzione letteraria latina. È infatti nel III sec. a. C. che “un’impensata ricchezza affluisce nelle case della classe dirigente romana”3: e dall’incontro fra le tradizionali aspirazioni di gloria e il nuovo gusto per i piaceri della vita nasce un desiderio altrimenti sconosciuto di cultura e di educazione letteraria, attività prima escluse dal paradigma educativo tradizionale, e, anzi, guardate persino con sospetto. La definitiva conquista della Grecia, poi, apre notoriamente per Roma una nuova epoca culturale e di pensiero, che intensifica, amplifica ed accelera quelli che erano i semi, già fecondi, gettati da Livio Andronico, Nevio, Ennio.
Quanto al genere storiografico, esso, fin dagli inizi, rappresenta la sola forma di attività letteraria percepita come compatibile con un’elevata posizione sociale e con una carriera pubblica: pensiamo a Catone, Cincio Alimento, Fabio Pittore, Postumio Albino; e se, secondo M. von Albrecht, il solo “vero scrittore” di questo gruppo è Celio Antipatro, probabilmente, il primo autore a Roma di una monografia storica, dobbiamo prendere atto del fatto che difficilmente, nei decenni di quella latinità che per comune consenso si definiva alcuni decenni orsono “aurea”, assisteremo a una tale fioritura di inventiva verbale e di raffinatezza linguistica.4
Fortunatamente, è in atto da decenni una revisione della nostra valutazione dell’arcaismo, momento storico ricco e fecondo, letterariamente, linguisticamente, dal punto di vista del pensiero poetico e giuridico e anche dal punto di vista del pensiero storico. In particolare, Cassio Emina rivela, come vedremo nel corso di questo lavoro, inaspettati momenti di razionalismo, che prende spesso le forme dell’eziologia, dell’etimologia, dell’eponimia e anche dell’evemerismo.
Del resto, Livio Andronico, con la sua Odusia in saturni non è certo contemporaneo di Omero, ma è invece contemporaneo dei poeti alessandrini. Per usare, ancora una volta, le parole di M. von Albrecht, in fondo anche “Livio Andronico è un poeta doctus ellenistico”5, la cui prassi letteraria reca il marchio di una riflessione filologicamente consapevole. E già nell’Odusia liviana è possibile riscontrare una particolare attenzione e sensibilità ai problemi di traduzione dal modello greco, che finirà per costituire un’autentica costante culturale nella storia della lingua letteraria, con il graduale trapasso verso soluzioni tecniche sempre più raffinate6. E così, anche Nevio e Ennio, Pacuvio e Accio, sono contemporanei dei più sofisticati autori della letteratura erudita sviluppatati sull’onda di Callimaco.7
Questo carattere della poesia delle origini può estendersi anche ad altri generi letterari. Se, infatti, la situazione della letteratura scenica ed epica è quella appena delineata, non si deve pensare che le personalità dedite alla storiografia fossero meno colte e brillanti, o portatrici di una visione della storia meno densa e raffinata. Se “esiste un divario cronologico immenso fra il sorgere in Grecia della riflessione critica sul passato (fra VI e V sec. a. C.) e le prime stesure letterarie della storia a Roma”8, esso non va inteso soltanto nel senso di una necessaria interpretazione della cultura arcaica latina in chiave ellenistico-alessandrina; in verità, “tale divario comporta non soltanto una distanza culturale, ma anche sociale e politica”9. La storiografia greca nasce come immediatamente interessata ai fatti politici, militari, istituzionali, della pólis; al contrario, lento è stato quello che potremmo chiamare il periodo di incubazione della comunità statale romana, che è andata consolidandosi e delineandosi nel corso del tempo, benché la tradizione storica più tarda, diventata poi, per così dire, canonica, si sia compiaciuta del descriverla come compiuta e coesa sin dai tempi più remoti, sino dalle sue origini. Ed è in tale quadro che, come afferma Gabba, andrebbe collocato il motivo per cui a un simile ritardo corrisponde anche una sorta di rinvio nella nascita di forme letterarie romane, caratterizzate immediatamente da un alto livello di elaborazione e sottigliezza formale e di pensiero.
Tito Livio, in 6, 1, si rende conto molto bene delle oscurità della storia di Roma arcaica, dalla fondazione sino all’incendio gallico, avvenimento dopo il quale l’Urbe è come rifiorita, quasi avesse subito una seconda fondazione:
Quae ab condita urbe Roma ad captam eandem Romani sub regibus primum, consulibus deinde ac dictatoribus decemvirisque ac tribunis consularibus gessere, foris bella, domi seditiones, quinque libris exposui, res cum vetustate nimia obscuras velut quae magno ex intervallo loci vix cernuntur, tum quod rarae per eadem tempora litterae fuere, una custodia fidelis memoriae rerum gestarum, et quod, etiam si quae in commentariis pontificum aliisque publicis privatisque erant monumentis, incensa urbe pleraeque interiere. Clariora deinceps certioraque ab secunda origine velut ab stirpibus laetius feraciusque renatae urbis gesta domi militiaeque exponentur.
Circa l’oscurità delle notizie relative alla Roma delle origini, Tito Livio presenta come spiegazione non soltanto il fatto che l’incendio gallico avrebbe comportato la distruzione degli archivi e di molte testimonianze; ma egli adduce a motivo anche la mancanza di una tradizione letteraria vera e propria risalente a quei tempi remoti, tradizione che sarebbe stata l’unica garanzia di fedeltà nel custodire la memoria degli avvenimenti del lontano passato. Ci si potrebbe allora chiedere a quale documentazione pubblica si riferisca Tito Livio: con ogni probabilità, esistevano raccolte di materiale documentario, quantunque sarebbe forse eccessivo parlare, prima del II sec. a. C., di archivi dei pontefici. Ma è innegabile che la conservazione di documenti e testimonianze del passato fosse connessa anche e soprattutto a scopi pratici,10 specialmente per quanto riguardava i testi giuridici, indispensabili per il mantenimento e l’esercizio del potere.
Inoltre, lo sviluppo stesso della prosa storiografica non poteva non essere influenzato da moduli di pensiero e forme espressive, tópoi e stilemi propri del mondo intellettuale e della storiografia greca. Catone stesso, ben lungi – come ben sappiamo – dall’incarnare lo stereotipo di avversario a priori della cultura greca, affermò, a proposito delle lettere greche che, sebbene non dovessero essere oggetto di uno studio approfondito, pure dovessero essere conosciute.11 Tale atteggiamento viene confermato dall’analisi di alcuni frammenti dell’opera storica catoniana, dai quali si può evincere come il Censore avesse una buona conoscenza della storiografia e della letteratura greche: pensiamo, in primis, all’episodio (cfr. Cato, Orig. frg. 76 = frg. 7Jordan4 = frg. 83 Peter2 = frg. 7 Chassignet = frg. 88 Cugusi), relativo all’eroismo di un tribuno della plebe. Aulo Gellio, attraverso il quale il passo ci è stato tradito (3, 7) ha riportato anche il nome del tribuno, Quinto Cedicio, che, invece, nelle Origines, in ossequio alla concezione collettiva della gloria romana tipica dell’opera, era taciuto. Il racconto è noto: una parte dell’esercito romano è bloccata dai Cartaginesi in Sicilia, presso Camarina, e la situazione sembra senza sbocco, quand’ecco che interviene un eroico tribuno della plebe, insieme a quattrocento soldati, pronti tutti a morire pur di attirare il nemico in una strettoia. Nell’episodio, in cui Gellio afferma di riportare, per la conclusione del racconto e le considerazioni finali sul fatto, esattamente il testo catoniano (Gell. 3, 7, 18, non iam nostris, sed ipsius Catonis verbis subiecimus) è, in filigrana, ben ravvisabile (anche se con alcuni particolari variati, come il numero dei soldati e la sorte del comandante) il paradigma del racconto che vede protagonisti gli Spartani alle Termopili. L’episodio, del resto, viene chiamato in causa direttamente, anche per mettere in rilievo la diversa sobrietà che connota il mondo romano rispetto a quello greco: Leonida venne onorato con statue, iscrizioni e altri segni di tributo (signis, statuis, elogiis, historiis aliisque rebus), mentre ben scarso merito (parva laus) venne riconosciuto al tribuno, che pure aveva compiuto un’impresa in tutto e per tutto analoga, salvando una situazione che sembrava disperata (qui idem fecerat atque rem servaverat).12
2 Cassio Emina: un Cato dimidiatus?13
In un simile panorama culturale, caratterizzato da molteplici suggestioni e fermenti intellettuali, si colloca anche l’opera di Cassio Emina. La pur scarsa quantità di testimonianze superstiti, poco più di una quarantina di frammenti, di lunghezza ineguale, ci consente comunque di gettare luce su un’interessante personalità intellettuale, che sarebbe ingiusto e limitante definire, con riferimento alla figura preponderante nella cultura del suo tempo, un Cato dimidiatus. Carlo Santini, nella sua edizione dei frammenti di questo storico, edita a Pisa nel 1995, e cui faremo riferimento nel corso di tale lavoro, ricorda infatti come, benché la memoria di tale personalità, certamente colta e dagli interessi vivaci e molteplici, sia pressoché svanita, tuttavia è proprio Emina la prima fonte ad attestare non poche circostanze dell’archaiologia di Roma14; non a caso, la maggior parte dei frammenti ci è giunta attraverso Servio e la letteratura antiquaria. Per esempio, in un brano del suo commento all’Eneide, a proposito del mito di Ercole e Caco, Serv. ad. Aen. 8 190, afferma che Cacus secundum fabulam Vulcani filius fuit … Veritas tamen secundum philologos et historicos habet hunc fuisse Evandri nequissimum servum et furem. Il commentatore, cioè, contrappone (tamen) la versione secundum fabulam (per cui, in questo caso, il personaggio è figlio di Vulcano) e quella secundum philologos et historicos, considerata più aderente al vero (veritas). Cassio Emina, per l’appunto, è uno di quegli historici et philologi: si noti l’accostamento delle due tipologie di studiosi, affiancate e accomunate dal fatto di sollevare il velame mitico delle fabulae.
Details
- Pages
- 126
- Publication Year
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783631912393
- ISBN (ePUB)
- 9783631912409
- ISBN (Hardcover)
- 9783631902042
- DOI
- 10.3726/b21421
- Language
- Italian
- Publication date
- 2024 (May)
- Keywords
- Cassius Hemina Republican historiography Evemerism Ancient rationalism Eponymy Numa Pompilius Pythagoreanism Romulus and Remus Cloaca Maxima Suicide by hanging
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024. 126 p.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG