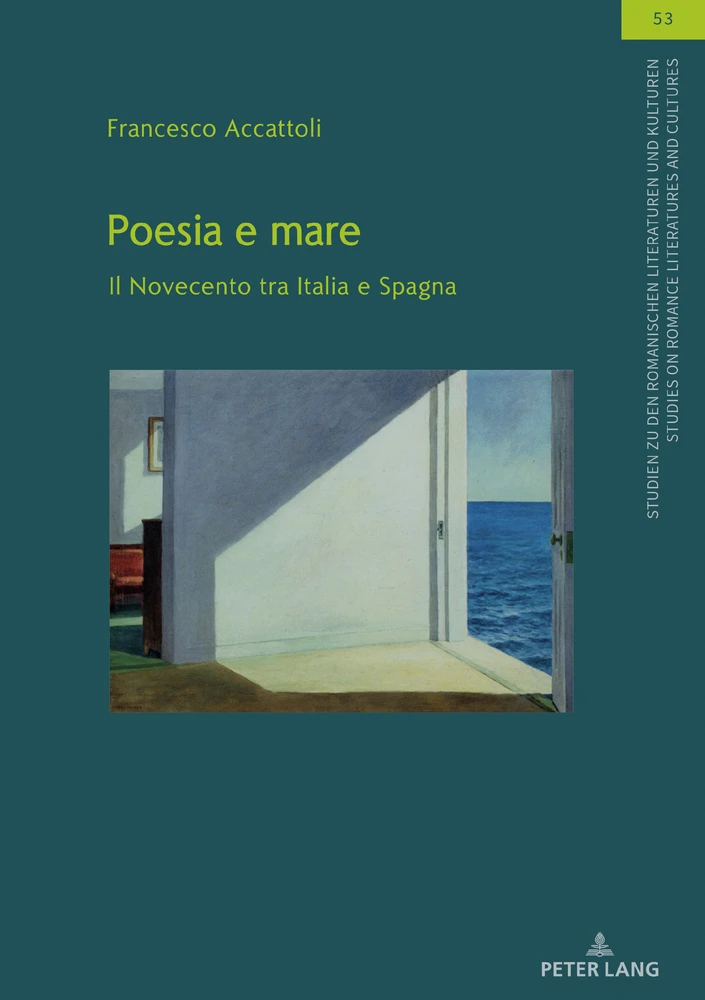Poesia e mare
Il Novecento tra Italia e Spagna
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Copertina
- Pagina del titolo
- Pagina del diritto d'autore
- Indice
- Prefazione
- Ringraziamenti
- Introduzione
- Capitolo Primo L’esperienza Del Mare Nella Poesia Greca E Latina
- 1.1 Il mare nell’epica greca arcaica: Omero ed Esiodo
- 1.2 Dalla lirica greca arcaica all’Ellenismo
- 1.3 La visione del mare a Roma, dall’epoca arcaica all’età augustea
- Capitolo Secondo L’esperienza Del Mare Nella Poesia Italiana Del Novecento
- 2.1 L’esperienza del mare negli Ossi di Seppia di Eugenio Montale
- 2.2 Giuseppe Conte e il ritorno al mare
- 2.3 L’Adriatico di Biagio Marin
- Capitolo Terzo L’esperienza Del Mare Nella Poesia Spagnola Del Novecento
- 3.1 Paraíso y memoria. L’«eterno ritorno» al mare di José Hierro.
- 3.2 Il mare visto da lontano. Il viaggio onirico di Rafael Alberti
- Conclusione
- Bibliografia
- Opere di Letteratura Greca e Latina
- Opere di Letteratura Italiana
- Opere di Letteratura Spagnola
- Opere Varie
- Apparato Critico
- Sitografia
Poesia e mare
Il Novecento tra Italia e Spagna

Berlin · Bruxelles · Chennai · Lausanne · New York · Oxford
Bibliographic Information published by the Deutsche Nationalbibliothek
The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data is available online at http://dnb.d-nb.de.
© Cover image: Rooms by the Sea, 1951, by Edward Hopper.
Courtesy of the Yale University Art Gallery.
Cover design by Peter Lang Group AG
ISSN 2511-9753
ISBN 978-3-631-93163-9 (Print)
ISBN 978-3-631-93161-5 (E-PDF)
ISBN 978-3-631-93162-2 (E-PUB)
DOI 10.3726/b22601
© 2025 Peter Lang Group AG, Lausanne (Switzerland)
Published by Peter Lang GmbH, Berlin (Germany)
All rights reserved.
All parts of this publication are protected by copyright. Any utilization outside the strict limits of the copyright law, without the permission of the publisher, is forbidden and liable to prosecution. This applies in particular to reproductions, translations, microfilming, and storage and processing in electronic retrieval systems.
This publication has been peer reviewed.
Indice
Capitolo Primo L’esperienza Del Mare Nella Poesia Greca E Latina
1.1 Il mare nell’epica greca arcaica: Omero ed Esiodo
1.2 Dalla lirica greca arcaica all’Ellenismo
1.3 La visione del mare a Roma, dall’epoca arcaica all’età augustea
Capitolo Secondo L’esperienza Del Mare Nella Poesia Italiana Del Novecento
2.1 L’esperienza del mare negli Ossi di Seppia di Eugenio Montale
2.2 Giuseppe Conte e il ritorno al mare
2.3 L’Adriatico di Biagio Marin
Capitolo Terzo L’esperienza Del Mare Nella Poesia Spagnola Del Novecento
3.1 Paraíso y memoria. L’«eterno ritorno» al mare di José Hierro.
3.2 Il mare visto da lontano. Il viaggio onirico di Rafael Alberti
Prefazione
Il saggio Poetiche del mare. Il Novecento tra Spagna e Italia di Francesco Accattoli è un’imbarcazione pensata non per raggiungere un porto, una terra, una meta, ma per esplorare un elemento, il mare, che da sempre sfida l’uomo, essendone al tempo stesso matrice. Non è forse nelle profondità dell’oceano, nella mar, come la poetica lingua degli andalusi (ma non solo) suggerisce, l’origine della vita? Una mar madre, che fa da pendant a un mare tutto al maschile, el mar, un mare fisico e dai tratti duri e severi del padre padrone. In questa diade, el mar/la mar – liricamente modulata in diversi componimenti di due poeti spagnoli, il gaditano Rafael Alberti e il cantabrico José Hierro, analizzati nelle pagine a seguire – s’inscrive l’irriducibile dualismo di ogni essere o cosa di questo mondo che è il leitmotiv del libro. Intorno ad esso si snoda un’ampia e ramificata riflessione sulla relazione – antropologica, come l’autore stesso tiene a precisare – tra il poeta e il mare, tra chi scrive poesie e chi viaggia in mare.
Mare o oceano? Non fa differenza. Si punta, qui, all’essenza prima dell’elemento, alla sua sostanza unitaria al di là di ogni pratica classificatoria, ai principi fondamentali di una relazione uomo-mare che ha generato nei secoli tante varianti quanti sono i poeti che vi si sono ispirati. Difficile e alla fin fine impossibile, anche in virtù dell’incontenibile mutevolezza dei due poli messi a confronto e del loro continuo reciproco rispecchiamento, tentare una pur sommaria classificazione. Se è vero che il mare ha condizionato il linguaggio umano e l’espressione poetica, è altrettanto innegabile, come opportunamente rileva lo studioso, che la poesia ha alterato l’umana percezione del mare. Le possibilità di interazione e combinazione tra le due istanze è dunque infinita.
Di poetiche al plurale si tratta, non a caso, in questo libro, di cui colpisce per l’appunto la varietà e l’ampiezza delle prospettive considerate, da quella testocentrica a quella antropologica, con tutte le gradazioni intermedie del caso (dall’esegesi classica alla comparatistica più estrema). Si parte, nello specifico, dalle origini, dalla tradizione classica greco-latina, e con un bel salto si ammara al Novecento, tra tutti il secolo che con maggior sistematicità ha interiorizzato e tematizzato (letterariamente parlando) l’umano oscillare tra orizzonti contrapposti (terra e cielo, stabilità e impermanenza, compiutezza e infinitezza) suggestivamente rappresentato dal perpetuo movimento delle onde e delle maree. E dalla terra, la Grecia, da cui ebbe origine la civiltà europea, si precipita agli opposti confini dello spazio mediterraneo, la costa italiana dapprima (Liguria e Friuli) e poi quella spagnola (Cantabria e Andalusia).
Accattoli fa tesoro di molti sguardi sul mare (dai poeti dell’antichità classica ai poeti italiani e spagnoli del Novecento) e costruisce a sua volta un suo sguardo, un proprio punto di vista, non dalla costa, dalla terraferma, ma dalla stessa incontenibile e ondulante materia che attraversa. L’approccio del saggio è infatti dinamicamente interdisciplinare. Critica letteraria, filosofia, geografia umana, antropologia, convergono e s’intrecciano al suo interno, lasciando emergere nel viluppo un denso reticolo di riflessioni e considerazioni che fluttua sulla materia esaminata, per l’appunto, come un’onda; un’onda che s’impenna e si avvolge su sé stessa, per poi defluire sulla terra e subito dopo ritirarsi per nuove immersioni ed evoluzioni. Il lettore si prepari, insomma, a una navigazione molto movimentata, “mar adentro”, ora in superficie (la dimensione prettamente testuale), ora in immersione (le stratificazioni tematico-semantiche e ideative), attraverso un mare che talvolta è una lingua che lambisce la terra o la spiaggia nelle quali si addentra, talaltra il maestoso, infinito orizzonte che chiama all’avventura e alla scoperta di sé. È così che, di contro a un Montale che ha scelto come punto di osservazione la battigia – “limen ontologico – nella lettura di Accattoli – che lo separa dall’incontro diretto con l’acqua” (p. 145) – troviamo un Alberti, l’autore di Marinero en tierra, composto nel 1924, prima dell’esperienza dell’esilio politico dalla Spagna franchista, tutto preso a traslatare immagini nostalgiche della terraferma in fondo al mare: giardini, valli saline e palazzi abitati da amabili “coltivatrici di orti sottomarini” (p. 325).
Più in generale, il libro di Accattoli è una meticolosa mappatura delle principali rotte tracciate nel vasto mare della poesia da poeti appartenenti a epoche e latitudini anche molto distanti tra loro. Si va dal viaggio per mare come esperienza di formazione e di confronto con l’ignoto, fissato come archetipo dall’Odissea, al mare come sbocco di una tensione irrisolta tra il desiderio di infinito e la realtà concreta dei testi di Eugenio Montale, al mare come orizzonte di congiunzione tra l’uomo e la natura evocato da Giuseppe Conte, al mare come spazio intimo e quotidiano che si trasforma in elemento spirituale e metafisico nella poesia di Biagio Marin, al mare come luogo della memoria per José Hierro e come paradiso perduto per Rafael Alberti.
Per ognuna di queste esperienze di creazione, Accattoli mette in moto un complesso dispositivo interpretativo, la cui efficacia è comprovata dalla lunga sperimentazione condotta durante l’elaborazione della tesi di dottorato discussa recentemente, con successo, all’Università di Malaga, di cui questo libro è diretta emanazione. Gioca a favore (aggiungo di mia iniziativa giacché nel saggio, molto opportunamente, non vi si fa riferimento) anche la sua personale esperienza del mare e della poesia. Il parametro “biopoetico”, ovverosia il fatto che i poeti coinvolti in questa scrupolosa esplorazione delle testualità marine del Novecento italo-spagnolo abbiano avuto un’esperienza diretta del mare e che i rispettivi dettati siano un impasto di letterarietà e vissuto così denso e così sottilmente stratificato da far dubitare che il letterario non sia più vissuto della vita stessa e il vissuto più “poetico” del letterario, è, del resto, assolutamente centrale alla composizione del libro. Ne è conferma che il recuperodei “segni di un’esperienza diretta con il mare” (p. 13) nei testi degli autori scelti sia espressamente indicato dall’autore, in apertura di libro, come il primo passo da cui muove l’intera ricerca. Che lo stesso Accattoli sia poeta e marinero (in senso albertiano), insomma, non può che aggiungere valore, carattere, originalità a uno scritto che si è fatto felicemente carico di una impegnativa e complessa indagine su un motivo poetico senza tempo (ma non fuori dal tempo) sul quale è stato letteralmente versato un mare d’inchiostro.
Roma, 2 febbraio 2024
Loretta Frattale
Ringraziamenti
È mio desiderio rivolgere i più sinceri ringraziamenti a coloro i quali hanno seguito da vicino, rendendolo possibile, il presente saggio, supportandolo e arricchendolo di suggerimenti sempre preziosi: alla Prof.ssa Rosario Arias, Direttrice del «Programa de Doctorado: Linguistica, literatura y traduccion» dell’Universidad de Málaga, per i suoi fondamentali incoraggiamenti e al Direttore della mia Tesi; al Prof. Alessandro Ghignoli, la mia più viva e profonda riconoscenza per la sua disponibilità, i suoi suggerimenti e i sempre preziosi incoraggiamenti; alla Prof.ssa Maria Gracia Torres Diaz, per il fondamentale e importante lavoro di tutoraggio; alla Prof.ssa Loretta Frattale dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per avermi fatto dono del suo tempo, della sua lettura e delle parole che accompagnano il presente lavoro. Non voglio dimenticare anche il contributo di altri accademici, come quello del Prof. Salvatore Ritrovato dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, presenza insostituibile e costante, ben oltre il trimestre propedeutico alla Menzione Europea.
Fare ricerca durante il COVID è stata un’impresa eroica, vorrei quindi mostrare la mia totale e incondizionata gratitudine a tutto il personale della Biblioteca Comunale “Cini” di Osimo, alla Biblioteca dell’Universidad de Málaga, dell’Università degli Studi di Macerata e dell’Università di Urbino, senza il cui aiuto, umano e intellettuale, il presente lavoro sarebbe stato privo della necessaria bibliografia. Mi sia concesso, infine, di riservare un ringraziamento speciale alla Prof.ssa Stefania Signorini, Dirigente del Liceo Scientifico “Livio Cambi” di Falconara Marittima, istituto nel quale insegno, per avermi concesso, senza alcun indugio, l’opportunità di lasciare momentaneamente il mio servizio di docenza per completare il mio triennio di dottorato.
Introduzione
Perché un’antropologia del mare nella poesia?
Gettare uno sguardo all’interno della produzione poetica italiana e spagnola del Novecento, cercando di recuperare dai testi degli autori scelti i segni di un’esperienza diretta con il mare, significa esporsi inevitabilmente alla necessità di operare una selezione, per certi versi ingrata, che circoscriva i nomi dei poeti a coloro che nel dialogo con l’elemento marino abbiano trovato un interlocutore privilegiato, una presenza rilevante nella costruzione di comportamenti, di attitudini, di culture che contribuiscono a rendere il mare non solo un oggetto letterario, ma anche un principio fondamentale a livello antropologico. Consapevoli della vastità del campo di ricerca, sia in termini di autori che di risvolti investigativi, quindi, abbiamo deciso di soffermarci su un preciso gruppo di poeti che nel mare ha mostrato di possedere un motivo comune in grado di definire e di ripensare la relazione dell’essere umano col suo spazio e, al tempo stesso, di raccontarlo: esperire il mare significa, prima di tutto, considerarlo al centro della propria vicenda esistenziale, non solo un tramite metaforico al quale ricorrere per dare vita ad una narrazione o, peggio ancora, uno sfondo paesaggistico idilliaco e vacanziero. Scrive a proposito Pedrag Matvejević (1991: 145), nel suo Breviario Mediterraneo: «Il mare non lo scopriamo da soli e non lo guardiamo solo con i nostri occhi. Lo vediamo anche come lo hanno guardato gli altri, nelle immagini e nei racconti che ci hanno lasciato: veniamo a conoscerlo e lo riconosciamo al tempo stesso.».
Siamo certi, infatti, che esista una differenza evidente nel racconto del mare, tra coloro che ne hanno letto e studiato1, affascinati dal corredo metaforico che via via si è sedimentato lungo i secoli, e coloro i quali, invece, oltre che al repertorio letterario, hanno potuto attingere a un’esperienza diretta, più o meno protratta nel tempo, che ha consentito loro di elaborare una visione dell’elemento marino più antropologicamente rilevante, e cioè d’inserirsi in quella relazione millenaria tra uomo e mare fatta di atteggiamenti, proiezioni e costruzioni di archetipi culturali. Per questo motivo, sulla scorta della riflessione di Dilthey sul valore della tradizione2, abbiamo ritenuto opportuno iniziare il nostro percorso d’indagine facendo riferimento all’antropologia del mare nella letteratura greca e latina.
È nostra convizione, infatti, che siano stati i poemi omerici, e in particolar modo l’Odissea, a raccogliere in forma letteraria le attitudini dell’uomo greco nei confronti del mare, per poi ri-trasmetterle, come corredo di valori, agli autori, alle letterature, alle culture successive, in particolar modo a quella romana, la principale responsabile della koiné mediterranea.
Attraversare la letteratura greco-latina ci ha consentito di osservare la nascita della relazione fra essere umano e mare e di registrare una serie fondamentale di tòpoi antropologici che solo in un secondo momento sono diventati letterari, fissandosi sulla pagina: «il mare di acqua passa nel mare di carta», senza dimenticare che «spesso, la riflessione e la migliore letteratura sul mare partono da esperienze concrete di spiagge e di onde.» (De Fiore, 2013: 275). Esiste, tuttavia, un processo contrario e ugualmente produttivo, mediante il quale è la letteratura, a sua volta, a operare un condizionamento decisivo nella visione del mare, stimolando suggestioni e guidando il pensiero, prima ancora del corpo, oltre la battigia, il limite ontologico che separa l’esistenza umana, terrestre e terrena, dall’enigmaticità dell’elemento marino. Se, dunque, osservassimo il combinarsi dei due movimenti, noteremmo che si tratta di un iter circolare, che dall’esperienza dell’uomo ritorna alla percezione dello stesso, utilizzando la letteratura, nel nostro caso i testi poetici, come vettore per esprimere un modo di essere nei confronti del mare.
La sintesi di questo percorso reversibile ci conduce direttamente al nucleo della nostra ricerca, fissato nella convinzione che il mare non possa essere confinato al ruolo di cartolina, di sfondo o di occasione narrativa, in prosa o in versi, senza che non si instauri con l’essere umano, ora non più semplice spettatore, una relazione che rifondi il senso del suo abitare il mondo3: «essere uomo significa: essere sulla terra come mortale; e cioè abitare.», scrive Heidegger (1991: 97), secondo cui il costruire è propriamente abitare. Attingendo brevemente alla ben più ampia riflessione del filosofo tedesco, non possiamo non interrogarci su cosa fondi l’approccio dell’uomo con il mare, elemento appartenente al globo terrestre ma inadatto ad essere edificato, e per ciò stesso inabitabile. Non si confonda la tèchne umana capace di costruire strutture, o addirittura città, sul mare. L’elemento marino è da sempre simbolo di movimento continuo, instabile e di difficile lettura, funge da separazione tra i continenti, tra le terre delimitate e definite dai confini (Rosenzwieg, 1917/2007: 83)4. Abitare il mare, dunque, si pone come iperbole ante litteram, come paradosso illusorio che attiva, di conseguenza, una serie di costruzione mentali che affidano all’eterno movimento delle correnti il mandato di rivelare il senso dell’alterità, di «rappresentare nell’ordine naturale l’imperfezione della dismisura.» (De Fiore, 2013: 145).
Perché dunque la necessità di ricostruire un’antropologia del mare, se è così evidente la condizione d’inappartenenza5 dell’uomo all’elemento marino?
La letteratura ci viene in soccorso come forma di palingenesi continua e privilegiata di una relazione costantemente tentata, alla quale l’essere umano non si sottrae nonostante, come scrive Jules Michelet (1861/2019: 11), il mare non abbia bisogno di lui.
La disparità tra l’infinitamente grande e la finitezza che caratterizza ogni aspetto dell’esistenza umana, viene sublimata attraverso la creazione di schemi emotivi e di posture che mettono in continua discussione la terrestrità dell’uomo e lo costringono a ri-leggersi e a ri-conoscersi. Nonostante il suo caparbio progredire, l’uomo non si trova munito nei confronti dell’elemento marino, nel senso del verbo latino munio: è privo di fortificazioni, prima di tutto mentali, per comprendere a fondo l’esperienza diretta con il mare.
Il ricorso ad una nomenclatura varia e particolareggiata6 da parte della cultura greco-latina per catalogarne le caratteristiche, il tentativo dell’uomo di dominare il mare, come racconta Carl Schmitt (1949/2002), imponendo una talassocrazia via via sempre più militarizzata, o di ridurne «l’immensità ossessiva, onnipresente, meravigliosa, enigmatica» attraverso lo sviluppo dell’ingegneria navale (Braudel, 1985/2019: 33), appartengono al medesimo sforzo delle civiltà di razionalizzare, o di reificare, per usare le parole di Dardel (1986: 27)7, ciò che produce inevitabilmente un senso di ridimensionamento e di paura (Sorcinelli, 1998: 129)8.
La ragione di tale apparente frattura con il mare, scrive Schmitt (1949/2002: 11), è da attribuire alla natura dell’essere umano9:
l’uomo è un essere terrestre, un essere che calca la terra. Egli sta, cammina e si muove sulla solida terra. Questa è la sua collocazione e il suolo su cui poggia, e ciò determina il suo punto di vista, le sue impressioni e il suo modo di vedere il mondo. Dalla terra su cui nasce e si muove trae non solo il suo orizzonte, ma anche il modo di camminare e di muoversi e l’aspetto. Di conseguenza chiama «terra» l’astro su cui vive, sebbene, com’è noto, la sua superficie si componga per quasi tre quarti di acqua e solo per un quarto di terra, mentre anche i continenti più grandi non fanno che galleggiarvi come isole.
Eppure, continua il giurista e filosofo tedesco, i popoli, nel processo di formazione del proprio pantheon religioso, non si dimenticano di assegnare al mare le sue divinità (Schmitt, 1948/2002: 12):
È significativo il fatto che l’uomo, quando non si trova su una costa, guardi spontaneamente dalla terra verso il mare aperto, e non, al contrario, dal mare verso la terra. Nelle reminiscenze remote, spesso inconsce degli uomini, l’acqua e il mare rappresentano il misterioso fondamento originario di ogni vita. La maggior parte dei popoli evocano nei loro miti e nelle loro leggende dèi e uomini non solo terrigeni, ma anche nati dal mare.
È sullo scontro tra Ulisse e Poseidone che la cultura occidentale costruisce il proprio archetipo del viaggio per mare (Ferroni, 2004: 115), riscattato soltanto in epoca augustea dalla missione dell’ecista Enea, grazie all’atteggiamento favorevole di Nettuno. A partire dai poemi omerici, il mare si popola di presenze che pongono l’uomo in continua tensione con se stesso, nell’atto di esercitare la sua volontà di attraversare l’elemento e di ritrovare un approdo sulla terraferma: nereidi e oceanine, come Calipso, che impedisce il nóstos ad UIlisse; sirene che attirano i marinai e li uccidono, ma che poi rinunciano alla vita nel mare per trasferirsi sulla terraferma, come nelle leggende nordeuropee10; mostri marini affamati come Scilla o le creature serpentesche che minacciano Andromeda e Laocoonte; gorghi profondissimi e letali, come Cariddi o il Maelström di Edgar Allan Poe. Ancora nel diciassettesimo secolo, scrive Rosanna Masiola Rosini (2006: 216), «mostri marini e sirene venivano avvistati: i marinai spagnoli dovevano depositare una dichiarazione giurata che non avrebbero disertato la loro nave se avessero incontrato delle sirene, e parimenti era proibito avere rapporti carnali con esse. Come le indigene, sono senza anima e forse sono cannibali.». Il senso della mostruosità sfida la ragione sul terreno della incapacità di comprendere e di dominare totalmente le innumerevoli variabili dell’universo marino.
Tra il mito e la civiltà, tuttavia, esiste una zona franca che accetta il mandato di diventare il luogo del rito in favore delle divinità del mare: la spiaggia si pone come spazio liminare tra la geometria immobile e rassicurante della terra e la non-forma del mare11, tra un nómos fondato sulla tradizione (Cacciari, 2008) e la distesa da cui «non nascono né vite né ulivo» (Cacciari, 1997: 16).
Il mare, scrive Caterina Resta (2012: 107), «urta costantemente con la terra che lo tiene a freno e gli dà misura, mentre la terra non può illudersi di dettare la sua legge assoluta, il suo immobilismo, ma deve scendere a patti con la mobilità del mare, che lungo le coste incessantemente la inquieta».
Il nómos della terra è inefficace dinanzi alla «legge rischiosa» di cui parla Montale12; nonostante ciò, spiega Hegel (1994: 217), al mare dobbiamo guardare come ad un principio unificatore:
Details
- Pages
- 372
- Publication Year
- 2025
- ISBN (PDF)
- 9783631931615
- ISBN (ePUB)
- 9783631931622
- ISBN (Hardcover)
- 9783631931639
- DOI
- 10.3726/b22601
- Language
- Italian
- Publication date
- 2025 (July)
- Keywords
- Poesia Mare Letteratura Italiana Letteratura Spagnola Traduzione Antropologia Filosofia
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2025. 372 p.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG