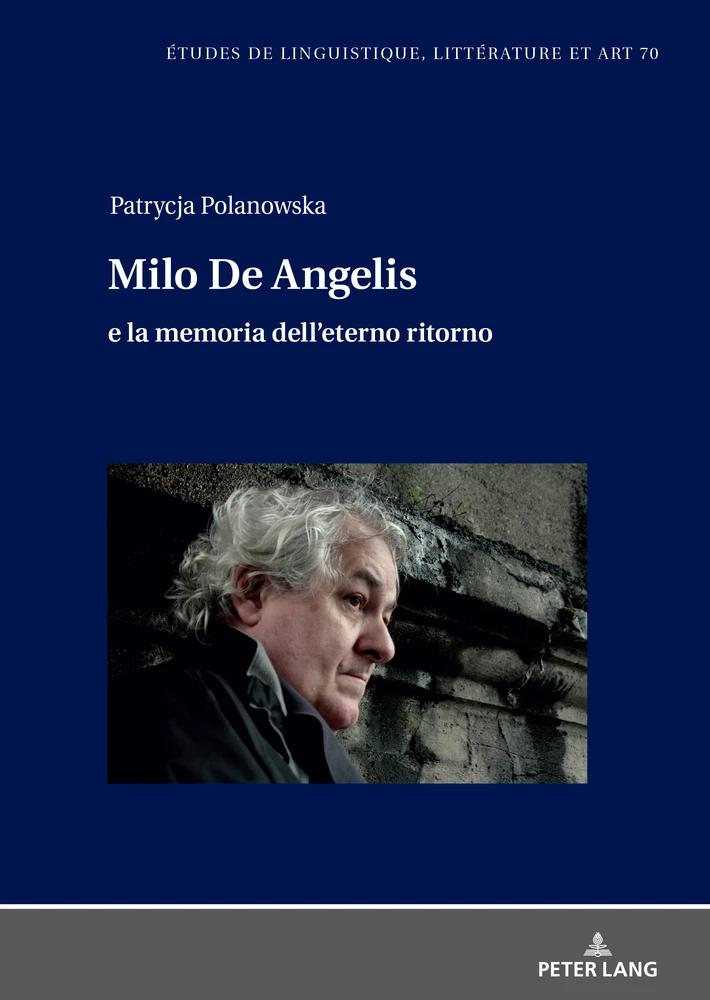Milo De Angelis e la memoria dell'eterno ritorno
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Copertina
- Titolo
- Copyright
- Sull’autore/Sul curatore
- Sul libro
- Questa edizione in formato eBook può essere citata
- Indice
- Introduzione
- Capitolo 1
- Sulla pluralità di approcci verso la memoria. Un percorso teorico
- Il ricordo e la memoria nel campo poetico. Riflessioni sul Novecento italiano
- Capitolo 2
- Il contesto storico-letterario della formazione deangelisiana
- Tra memoria e oblio. Lo status del soggetto poetico
- Presenze e assenze. Milano come oggetto della memoria poetica
- Capitolo 3
- Il significato della memoria nell’opera di De Angelis
- Sulla memoria identitaria del primo De Angelis
- Le voci della stagione tarda
- Conclusione
- Appendice
- Bibliografia
Introduzione
Sì, in questo ritorno c’è un luccichio di tutto l’essere,
un risveglio che sta per avverarsi, il senso di una
rivelazione imminente. E noi iniziamo ad ascoltare.
Milo De Angelis
Bolesław Leśmian, nel suo saggio intitolato Z rozmyślań o Bergsonie dichiarò: «Prima il battito del cuore, solo dopo il senso d’ansia…»1. Con quest’affermazione egli rivendicava un’origine irrazionale della ricerca sia poetica che filosofica, nonché l’oscurità del loro oggetto più profondo. Con ciò non si pretendeva però una rimozione dell’aspetto razionale della scrittura, anzi. Il ragionamento e la stessa modalità espressiva, dovevano essere estremamente puntuali e precisi. Una simile prospettiva venne assunta anche da Milo De Angelis (1951) che conobbe i componimenti dell’autore polacco già all’inizio della propria vita poetica. A un esame più attento, però, tale vicinanza tra i due poeti non porta a individuare molte affinità tematiche o stilistiche, poiché ad essere centrale in questo rapporto è, per l’appunto, l’atteggiamento nei confronti della lingua, il suo ordine che non limita la libertà creativa e neanche sopprime la componente irrazionale.
L’oscurità dei testi di De Angelis non proviene tanto dagli influssi della poesia pura, essendo piuttosto un’eco della lezione dello stile dell’imparafrasabile, proprio di Maurice Blanchot, il quale, richiamandosi ne L’Espace littéraire all’atto di Orfeo, spiega l’irrazionalità dell’atto della scrittura che si svolge «come se ciò che noi chiamiamo l’insignificante, l’inessenziale, l’errore, potesse, a chi ne accetta il rischio e vi si abbandona senza riserve, rivelarsi come la fonte di ogni autenticità»2. E De Angelis è proprio un autore che decide di abbandonarsi al rischio che la scrittura poetica richiede. L’irrazionalità coincide in questo atto con un imperativo ineludibile di estrema precisione. Tale approccio lo apparenta anche ad alti autori cui fa riferimento nelle proprie opere, in primo luogo Lucrezio, Leopardi, Rimbaud, Artaud, Bonnefoy, Celan, Benn e Cvetaeva.
Tale natura della poetica deangelisiana determina anche le dinamiche della sua ricezione da parte del pubblico e il principio indicato da Leśmian sembra reggere le stesse letture critiche. Il fatto è che la sua opera poetica, pur avendo presto suscitato un interesse vivace sia tra il pubblico specializzato, sia tra quello generalista, viene affrontata in maniera complessiva solo in pochissimi studi. La parte più attenta del pubblico aveva, per l’appunto, riconosciuto subito il valore della raccolta d’esordio di De Angelis, Somiglianze, il suo muoversi contrastando la crisi, da molti sentenziata, nei confronti della poesia come valore ed esperienza elettiva. Walter Siti riassumeva nel modo seguente il suo primo incontro con la poesia deangelisiana e la sua esperienza di lettura dei suoi componimenti:
Quando nel 1976 uscì Somiglianze […] ricordo di aver provato un senso di liberazione: nei dieci anni precedenti la poesia in Italia aveva rischiato il soffocamento. Prima la neoavanguardia l’aveva spolpata e razionalizzata, poi l’aveva colpevolizzata il Sessantotto; i due poeti forse più in vista, Montale e Pasolini, per motivi diversi avevano smontato i loro versi con ironia o con rabbia. L’impegno politico sembrava così urgente che perder fiato e intelligenza con la poesia era roba da vergognarsi come di un passatempo per reazionari. (Solo un’antologia di Cordelli e Berardinelli, l’anno prima, aveva lasciato intravedere un fermento)3.
Il “senso di liberazione” di cui parla Siti sta alle fondamenta dell’opera di De Angelis, ma si evidenzia anche nell’impostazione assunta dalla rivista «Niebo», fondata dopo un soggiorno del nostro autore a Varsavia a cavallo tra il 1976 e il 1977. Questo progetto editoriale divenne uno spazio esemplare per il colloquio tra poeti, tendenze, epoche. Ma lo stesso colloquio risuona anche nei versi deangelisiani, diventando il principio della costruzione della realtà poetica. La centralità del dialogo ci permette di riconoscere la strada per il superamento dell’impossibilità di un’esegesi esaustiva dei suoi versi, la quale non si pone più come ostacolo insuperabile, ma come prospettiva nuova che porta a riletture sempre aperte e sempre vitali. Il rapporto dialogico di cui si parla, collega, in primo luogo, il passato con il futuro e così stabilisce la principale linea interpretativa del nostro lavoro, incentrato sul funzionamento e sul ruolo della memoria poetica intesa come incontro tra due orizzonti temporali, non come subordinazione dell’uno all’altro.
Per introdurre la nostra ricerca incentrata sui testi poetici, il saggio parte dalle riflessioni filosofiche, storico-culturali e sociologiche che hanno puntato a mettere a fuoco il complesso argomento della memoria: da Paul Ricœur a Pierre Nora, da Maurice Halbwachs ad Aleida e Jan Assmann, attraversando alcuni concetti nati nel campo dei memory studies. Presentato questo panorama, si scopre la necessità di affrontare ancora le teorizzazioni connesse all’argomento della temporalità, a partire dalla sua elaborazione nell’epoca antica per arrivare alla svolta avvenuta a cavallo tra Otto e Novecento, e divulgata da Stephen Kern nel suo famoso libro del 1983, The culture of time and space, 1880–1918. Da tale percorso emergono due declinazioni principali della memoria: quella che la fa intendere come ars, dove il processo di memorizzazione viene legato alla creazione dei loci, e quella che domina a partire dalla svolta romantica e intende la memoria come vis, dunque come forza, vigore, efficacia espressiva. Ed è proprio la seconda accezione quella che intendiamo porre a fondamento della nostra analisi. Spostandoci verso l’epoca contemporanea, risulta sempre più indispensabile un riferimento alle idee di Friedrich Nietzsche, Edmund Husserl, Henri Bergson e Martin Heidegger, che, essendo pensatori essenziali per la comprensione delle dinamiche novecentesche, fanno da bussola al nostro discorso. Con loro si conferma la dialogicità della memoria, intesa nel suo sviluppo temporale. Claude Romano, analizzando l’approccio di Husserl, avrebbe notato: «Il tempo nasce e si dispiega proprio nel “entre-deux” fra “soggetto” e mondo, e questo è il motivo per cui non ha senso ricercarvi un’unica origine: è la struttura che si verifica nel loro incontro»4.
L’attenzione rivolta alle teorie filosofiche ci permette inoltre di riconoscere il significato della categoria del ritorno (cui si accostano i concetti della ripetizione e della ripresa). Il nostos, fondato originariamente sul poema omerico dell’Odissea, si mostra come radice della nostalgia romantica, sintomo dell’impossibilità di dimenticare o perdonare, ma anche come meccanismo che rende possibile il dialogo tra i tempi. In questa seconda accezione cambia (o più precisamente si distende) la direzione del ritorno stesso. Non si parla, per l’appunto, del ritorno al passato, ma del passato, ossia di un secondo incontro con gli elementi del vissuto che non punta a sottrarci al presente. Alla scoperta di questo modello si arriva con Kierkegaard, per superare infine anche la sua proiezione dei desideri verso il futuro: qui il fondamento decisivo viene posto da Nietzsche (con l’eterno ritorno) e da Bergson (con il significato della durée).
Tale passaggio ci porta anche ad uscire oltre la distinzione tra ricordo soggettivo-episodico e memoria oggettivo-storica: cruciale è qui il riconoscimento della centralità del momento presente. Partendo da questo punto diventa possibile avviare un dialogo con il passato, un dialogo basato sulla memoria e sui ricordi che sono ora da intendersi come momenti di intensificazione della memoria, echi di un’estrema attenzione concessa al vissuto. Privilegiando tale ottica si arriva anche alla possibilità di superare l’egocentrismo che, come ci insegna Freud, sta alla base della malinconia destata dal ricordo di un oggetto che ci è stato tolto, rendendoci incapaci di continuare la vita nel presente. Le stesse dinamiche riguardano anche il concetto francese della rêverie. Analizzandolo, Gaston Bachelard ci fa vedere la poesia proprio come frutto dell’immaginazione artistica radicata nella malinconia e nella speranza.
Ma il dialogo ritorna nel presente saggio anche come strumento e categoria dell’analisi, radicato in questo senso nell’approccio ermeneutico di Gadamer. Rivolgere lo sguardo verso i testi dei grandi poeti del Novecento, per arrivare infine a Milo De Angelis, non serve ad antologizzare questi autori, ma a riattualizzare le loro parole nell’orizzonte di una lettura non ripiegata nella propria intimità, ma che tenta di proporre uno sguardo più ampio sulle possibilità e sui limiti della produzione di senso nella poesia contemporanea.
Nel secondo Novecento osserviamo un netto allontanarsi dei poeti dal ricordo inteso come forza estetica che permette di trasfigurare e sublimare il vissuto. In sua vece abbiamo una riflessione fortemente esistenzialista, dove il passato permette di fare i conti con la propria condizione presente. Ciò succede anche nell’opera di De Angelis, in cui la memoria e il ricordo non sono strumenti adoperati per creare immagini, ma rappresentano in definitiva principi costitutivi della stessa scrittura poetica. Così, svolgendo un’analisi critica, non possiamo limitarci alla ricerca tematica poiché, là dove il tema della memoria non si esplicita, verrebbe meno addirittura lo stesso oggetto dell’analisi. Per una migliore comprensione del caso di De Angelis non si scelgono, come obiettivo della ricerca, poeti che in primo luogo trattano del tema della memoria, mettendola al centro del loro immaginario, ma si riflette su alcune dinamiche del discorso poetico, da Umberto Saba a Giovanni Giudici, da Eugenio Montale a Vittorio Sereni, dettate dal rapporto con il passato. Per riconoscere il ruolo della memoria in questi autori bisogna condurre un esame puntuale dello sviluppo e delle dinamiche di tutto l’immaginario poetico, dove la memoria viene intesa come meccanismo profondo che ne decide il corso. È centrale qui il rapporto dialettico tra Bedeutung e Sinn, tra significato e senso, da cui nasce, secondo Gadamer, un’opera poetica5. Come ricorda Romano Luperini, infatti, «La critica non registra oggettivamente. Non si limita a descrivere, ma formula ipotesi di senso. È parte in causa, partecipazione interpretante»6. Seguendo l’approccio ermeneutico si può, per l’appunto, cercare il senso della memoria poetica presente in De Angelis, non esplicitarne il significato unico. Con quest’affermazione entriamo in sintonia con le parole del nostro poeta, il quale, nel suo saggio del 1976, si opponeva, sulla scorta della riflessione su Maurice Blanchot, proprio al «mito illuministico» della scrittura critica: «non esiste l’“aggiunta” di una messa a fuoco che chiarisce qualcosa di oscuro (il testo) ma piuttosto un’altra oscurità che progressivamente si chiarisce, tenta di chiarirsi procedendo insieme al testo letterario»7.
Seguendo quest’approccio, la dialogicità ci permette quindi di stabilire la stessa prospettiva metodologica, dove le osservazioni riguardo ai quadri critici complessivi si uniscono con le scoperte di contenuti specifici e profondi. A questo punto si attinge fortemente al pensiero di Michail Bachtin, ma anche a quello di Walter Benjamin, i quali ci fanno intendere il dinamismo di tale approccio critico, ma anche la sua efficacia al fine di intendere il significato e la rilevanza di un’opera. Quest’importante corrispondenza tra i due studiosi è stata colta da Ezio Raimondi che scrive:
In base alla sua funzione Bachtin distingue tra un commento come «razionalizzazione», pur se relativa, nella sua congenialità alla tradizionale «analisi scientifica», e «un’interpretazione artistico-filosofica» come «approfondimento» di uno mediante altri sensi. Il primo potrebbe corrispondere all’accertamento dei dati che Benjamin e Adorno attribuiscono al contenuto fattuale, mentre il secondo si orienta probabilmente verso il contenuto di verità8.
Avendo riconosciuto la rilevanza del rapporto dialettico tra dinamiche generali e testo poetico, si mantiene questa tensione tra varie parti del lavoro. Nel capitolo introduttivo essa si realizza tra la riflessione teorica sulla memoria e il modo di relazionarsi con quest’ultima di alcuni poeti del Novecento. Tra il secondo e il terzo capitolo si opera invece uno scambio tra teorico e pratico, ovvero tra la rappresentazione delle coordinate principali per la costruzione del discorso sulla memoria poetica e un percorso interpretativo basato sui versi di De Angelis.
Nel corso del primo capitolo, oltre ad aver esaminato il contesto storico-culturale e le basi metodologiche, si è esplicitato il ruolo del soggetto e dell’oggetto nel processo della costruzione della memoria. E sono proprio queste le due coordinate da considerare nella ricerca successiva. Seguendo tale constatazione, il capitolo secondo si articola in tre paragrafi. Il primo viene dedicato all’ambiente della formazione di De Angelis, il secondo all’importanza dell’io nel contesto delle riflessioni sulla memoria, con una particolare attenzione rivolta alle tendenze degli anni Settanta, mentre il terzo viene incentrato sull’oggetto in cui si radicano i ricordi degli esseri umani, e conseguentemente anche sullo spazio milanese che diventa la matrice essenziale del mondo del nostro autore.
Eseguita questa parte dell’analisi, si passa al capitolo più interpretativo del nostro lavoro. Nella prima sezione si cerca di mettere in evidenza le dinamiche fondamentali per la comprensione del tema della memoria nella poesia di De Angelis. Un ampio spazio viene dedicato qui ai primi giudizi critici sull’autore di Giorgio Bàrberi Squarotti e Roberto Mussapi, per arrivare infine alle recenti voci dei critici più autorevoli dell’opera di De Angelis, tra cui soprattutto quelle di Alessandro Baldacci e di Luigi Tassoni. Vengono qui rilevati anche i grandi temi della poetica deangelisiana, affrontando dunque il suo rapporto con l’orfismo e con il tragico, ma indicando altresì alcune affinità con altri autori come Angelo Lumelli o il già menzionato Bolesław Leśmian. Tale quadro critico ci permette di definire meglio l’impostazione dell’opera del nostro poeta. Nel secondo e nel terzo sottocapitolo seguiamo invece il suo sviluppo diacronico, distinguendo due fasi principali della sua produzione letteraria. La prima, analogamente a ciò che si è osservato in precedenza, mostra la memoria come forza che permette di costruire l’identità dell’io. In Somiglianze e in Millimetri non troviamo ancora ritorni memoriali ad ampio raggio, dato che tutto il passato è vicino e i ricordi aderiscono strettamente al presente. La seconda stagione, aperta con Biografia sommaria, presenta ritmi più distesi, in cui l’attenzione principale si focalizza sull’esterno che parla con le sue voci, entrando in colloquio con il presente, proprio dell’io empirico.
Il taglio critico delle nostre analisi rimane eclettico e non si assume come modello metodologico un’unica teorizzazione, sebbene tali tentativi siano già stati intrapresi e hanno portato a esiti notevoli, come nel caso del saggio di Alberto Russo Previtali, Milo De Angelis: la contingenza e l’alterità, in cui si evidenziano le implicazioni psicoanalitiche del concetto deangelisiano di memoria9. Riconoscendo però un legame fortissimo, nel caso della scrittura lirica o vicina al lirico, tra autore e io parlante, applicare un metodo psicoanalitico significa in realtà sottoporre a esame la psiche del poeta, non il testo. Sotto quest’aspetto restiamo dalla parte di Contre Sainte-Beuve e la biografia ci interessa solo nella misura in cui opera in funzione del testo. Al tempo stesso si tengono presenti i limiti dell’approccio che vuole vedere un’opera d’arte come contenitore di messaggi, rischiando in tal modo di analizzarne solo l’“esteriorità”. Nell’ottica che assumiamo la parola poetica tende a coincidere, per i suoi tratti caratteristici, con la memoria. È relazionale e unica, personale e autonoma. La realtà poetica nasce con il risuonare della parola e finisce nel bianco della pagina: in questo spazio si evidenzia tutta la memoria su cui ci vogliamo concentrare. Il più vicino al nostro percorso sarà quindi l’approccio del già menzionato Gadamer che privilegia quale base dell’approccio critico lo stesso processo di lettura, dove leggere significa «lasciar parlare»10.
Nel corso di questa presentazione si spiega anche il titolo del nostro saggio. Al concetto nietzschiano dell’eterno ritorno ci rimanda infatti lo stesso De Angelis, facendo a più riprese riferimento al pensiero del filosofo tedesco11. Conseguentemente il termine chiave di questo lavoro diventa ‘memoria’, qui intesa come struttura profonda della creazione poetica che non offre all’uomo un rifugio idealizzato, ma si apre alla vita, rende disposti a ripetere il vissuto. Anche il ricorso al dialogismo si insedia nella stessa costruzione del titolo, fondato su una relazione espressa per metonimia tra soggetto e oggetto, non un’appartenenza dell’uno all’altro, secondo un rapporto di sovranità. Quest’incontro possiede inoltre una valenza plurima: significa relazionarsi con il proprio vissuto, ma anche affrontare il cambiamento delle dinamiche nella poesia del secondo Novecento: esaminarne le possibilità e i limiti. Legando semanticamente la memoria al ritorno punteremo a mettere ulteriormente in luce il suo aspetto attivo, non riducibile a un archivio di fatti. L’aggettivo ‘eterno’ non ci permetterà invece di pensare a brevi momenti di riscatto, offerti dall’illuminazione epifanica, ma ci condurrà verso un continuo confronto con il vissuto e una contemporanea vitalità del testo poetico. Chiudendo la parte introduttiva, vogliamo ancora segnalare che il 14 aprile 2022, quando il titolo del nostro saggio (che era allora il titolo della tesi di dottorato) era già stato convalidato, è uscito per la collana Le parole della poesia di Vallecchi un volumetto dei testi di De Angelis che l’autore ha deciso di intitolare proprio Ritorno, come sigillo del suo percorso poetico.
Carica di sensi, la voce del nostro poeta ci turba, ma al tempo stesso ci attira a tal punto che, nonostante tutto, aprendo questo saggio, quasi ci si vorrebbe ritirare e ripetere con Giuseppe Conte: «non vorrei mai scrivere “criticamente” su De Angelis. A lui non posso che dedicare pensieri amorosi, deliri, aforismi, profezie, elegie»12.
1 Bolesław Leśmian, Z rozmyślań o Bergsonie, in Szkice literackie, a cura di Jacek Trznadel, PIW, Warszawa 1959, p. 35: « Najpierw bicie serca, a potem dopiero uczucie lęku…».
2 Maurice Blanchot, Lo spazio letterario, trad. it. Gabriella Zanobetti, Einaudi, Torino 1975, p. 149; L’Espace littéraire, Gallimard, Paris 1955, p. 182: «comme si ce que nous appelons l’insignifiant, l’inessentiel, l’erreur, pouvait, à celui qui en accepte le risque et s’y livre sans retenue, se révéler comme la source de toute authenticité».
3 Walter Siti, De Angelis il fragile destino di un amore, «la Repubblica», 30/03/2014, disponibile su: https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/03/30/de-angelis-il-fragile-destino-di-un.html (ultimo accesso 04/07/2024).
Details
- Pages
- 278
- Publication Year
- 2025
- ISBN (PDF)
- 9783631929353
- ISBN (ePUB)
- 9783631929360
- ISBN (Hardcover)
- 9783631919040
- DOI
- 10.3726/b22495
- Language
- Italian
- Publication date
- 2024 (December)
- Keywords
- memoria ricordo tempo nostalgia soggetto oggetto spazio
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2025. 278 pp.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG